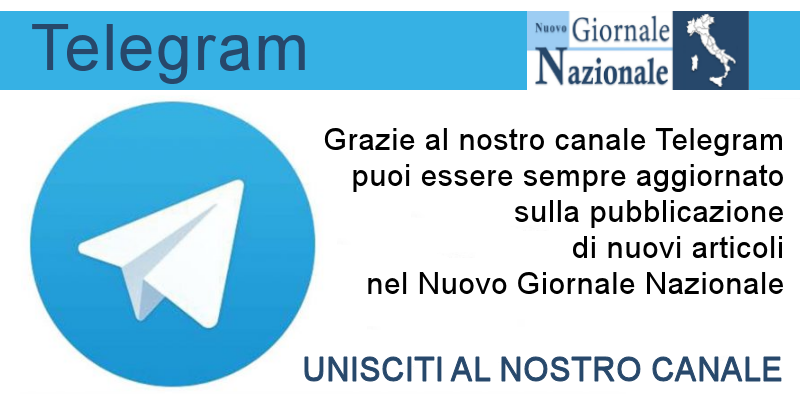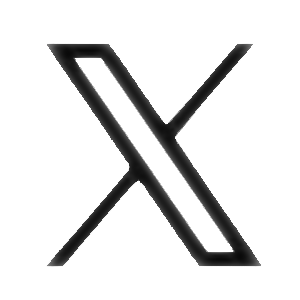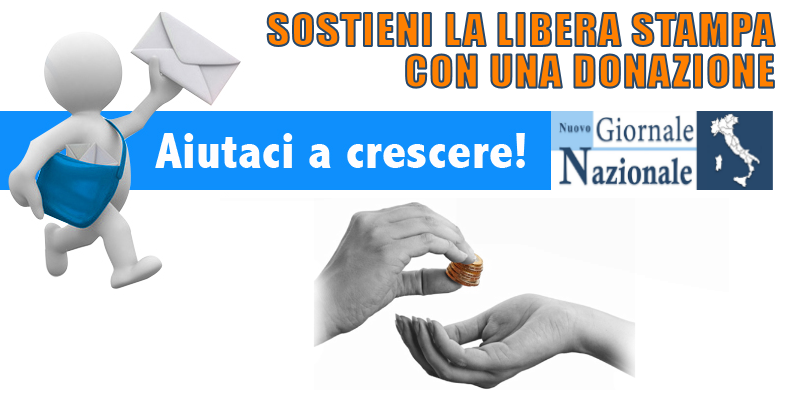di Antonio Foccillo
In questi ultimi tempi si sono aperte varie polemiche sullo sciopero generale promosso dalla Cgil e su quando dovrebbe essere fatto. Per questo voglio fare un rapido excursus sulla nascita, sulla dimensione e sulla legittimità dello sciopero.
Lo sciopero è la più importante forma di lotta a disposizione dei lavoratori per dar voce alle loro rivendicazioni. Nacque, anche se vi sono varie tesi e interpretazioni, quando il secolo ‘800 iniziò a convergere verso il secolo ‘900.
Quel periodo è considerato il momento di inizio della consapevolezza di avere diritti da rivendicare sul piano del rapporto di lavoro e per dar sostanza alle rivendicazioni. Si afferma così lo strumento dello sciopero quale elemento da utilizzare in caso di rifiuto da parte del datore di lavoro di riconoscere le istanze dei lavoratori.
In tale epoca denominata rivoluzione industriale, fu usato come mezzo di protesta nei confronti dei datori di lavoro, prima dagli operai dell’industria e in seguito da tutte le categorie di lavoratori, che dovettero affrontare dure lotte per poter manifestare liberamente e rivendicare salari più adeguati e condizioni di lavoro più umane.
Il cammino che ha portato alla conquista di questo diritto non è stato facile e per lungo tempo la risposta alla protesta degli scioperanti è stata la repressione.
Soltanto verso la fine dell’Ottocento, quando i lavoratori hanno fatto ricorso sempre più frequentemente all’astensione dal lavoro per rivendicare i propri diritti si è delineata una certa tolleranza.
In Italia le prime manifestazioni di protesta dei lavoratori per le misere condizioni di vita iniziarono subito dopo l’unificazione del Paese, interessando sia le campagne del Sud sia le fabbriche del Nord.
I conflitti sociali divennero ancora più aspri nei primi anni del XX secolo e più volte sfociarono in scioperi generali. Agli inizi del Novecento, in seguito all’introduzione di riforme tese a migliorare le condizioni di lavoro (orario, tutela delle lavoratrici durante la gravidanza, età minima a 12 anni per l’impiego dei fanciulli), vennero riconosciute anche alcune libertà fondamentali, tra cui il diritto di sciopero, ritenuto uno strumento lecito durante le lotte sindacali.
In Italia lo sciopero era considerato reato nel codice penale sardo del 1859. Solo, nel 1989, con l’emanazione del codice penale Zanardelli non lo fu più, salvo quello violento e anche dopo quel codice penale non fu pienamente riconosciuto fino al 1904, quando la Camera del Lavoro di Milano organizzò uno sciopero generale (di tutte le categorie lavorative) per partecipare a una discussione politica di quel momento.
Con il Codice Rocco del 1930 si ritornò alla repressione dello sciopero considerandolo un delitto contro la pubblica amministrazione per l’interruzione di un pubblico servizio.
Soltanto con l’entrata in vigore della Costituzione lo sciopero è stato riconosciuto come un diritto. Esso è stato inserito all’articolo 40 della Costituzione che rimanda al legislatore ordinario la regolamentazione della libertà di sciopero.
La formula adottata dell’articolo 40 della Costituzione per garantire questa libertà è ampia, piuttosto generica e dato che il legislatore non ha provveduto tempestivamente a disciplinare l’esercizio del diritto di sciopero, di fatto l’ambito e le forme accettabili si sono delineate poco per volta.
Il riconoscimento del diritto di sciopero conferisce al principio di libertà di organizzazione espresso nell’art. 39 Cost. e in particolare all’organizzazione sindacale, un forte strumento di effettività dando allo sciopero il ruolo di strumento giuridico atto a rimuovere la disuguaglianza sociale effettiva che caratterizza la posizione del prestatore nei rapporti con il datore di lavoro.[i]
L’aspetto più importante è che il diritto di sciopero esplica i suoi effetti anche nei rapporti intersoggettivi privati, inibendo al datore di lavoro la possibilità di compiere, nella gestione dei rapporti di lavoro, atti diretti a mortificare l’esercizio di tale diritto.
Lo Statuto dei lavoratori successivamente intervenne e stabilì che alcuni comportamenti (aumentare la busta paga a chi non sciopera o diminuirla agli scioperanti più del salario giornaliero) fossero in contrasto con tale diritto come comportamento antisindacale. Questi atti sono illeciti anche quando lo sciopero è stato vietato dalla precettazione.
Anche su sollecitazione della giurisprudenza costituzionale si svilupparono inoltre negli anni ’80 del secolo scorso, vari tentativi da parte delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori di dettare una autodisciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nei diversi settori di esercizio di servizi ritenuti essenziali, orientata appunto soprattutto alla garanzia, durante lo sciopero, di un minimo indispensabile nella relativa erogazione; tentativi sostanzialmente falliti per la limitata efficacia soggettiva di tale disciplina, riguardante unicamente il sindacato che l’aveva predisposta e i suoi soli iscritti, con esclusivo riguardo agli scioperi da esso proclamati, lasciando, soprattutto, ai sindacati autonomi la libertà di continuare, dato che essi non avevano aderito all’autoregolamentazione.
Successivamente fu approvata una legge – la 146/90 - per definire le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. La disciplina legislativa dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali si è uniformata allo schema operativo delineato dalla giurisprudenza costituzionale, individuando un elenco tassativo di diritti della persona, in ordine ai quali la legge è diretta ad assicurare il contemperamento con l’esercizio del diritto di sciopero, attraverso la disciplina di quest’ultimo nei servizi pubblici deputati ad assicurare il godimento di quei diritti.
La legge, per maggiore chiarezza, contiene anche un elenco, peraltro meramente esemplificativo, dei servizi ritenuti essenziali, raggruppati secondo il diritto della persona al cui soddisfacimento sono preordinati.
A mio giudizio lo sciopero va inquadrato come diritto assoluto della persona. Qualificare lo sciopero come diritto assoluto della persona consente la partecipazione di tutti i lavoratori al dibattito politico, economico e sociale, che certamente non poteva essere circoscritto alla dimensione aziendale. Tale diritto è riconosciuto a tutti i lavoratori subordinati, pubblici e privati, a esclusione degli appartenenti alle forze armate e dei lavoratori della polizia.
Se guardiamo allo sciopero come diritto assoluto della persona condizionato all’esistenza di un contratto di lavoro, ma non necessariamente inerente al datore di lavoro – possiamo giungere a una definizione più comprensiva, più adeguata dello sciopero ammettendo la sua legittimità sia sotto il profilo penale che privatistico anche dello sciopero di solidarietà e di quello diretto a esercitare una pressione sulla pubblica autorità per influenzare i provvedimenti che riguardano le condizioni di lavoro (il cosiddetto sciopero economico-politico).
A questo punto sorge una altra domanda: se è un diritto assoluto della persona può essere limitato da interventi successivi che ne stabiliscono gli ambiti e le regole?
Essendo garantito anche per i dipendenti pubblici dalla Costituzione, per legge si stabilì il contemperamento fra diritto di sciopero e altri diritti costituzionali, ma questo a parer nostro, non può comportare una compressione totale del primo.
Se, allora, lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito, come altri diritti fondamentali delle persone, essi sono tutti uguali e vi è fra i diritti una gerarchia? In quanto se si riconosce il diritto di fare sciopero solo se non si violano altri diritti anch’essi garantiti dalla Costituzione, come avviene nel settore pubblico e nei trasporti, i due diritti non sono sullo stesso piano.
Il problema è di stabilire, quali diritti sono sovra-ordinati o almeno para-ordinati e quali sono sotto-ordinati. Per alcuni di essi, come il diritto alla vita, o all’integrità fisica, non vi sono dubbi: essi sono certamente sovraordinati rispetto al diritto di sciopero. Più dubbia è la posizione di altri diritti, che trovano un riconoscimento diretto o indiretto nella Costituzione, rispetto al diritto di sciopero.
Purtroppo sull’utilizzo dello sciopero e, in particolare, sullo sciopero generale hanno sempre pesato le contrapposizioni fra le anime massimalista e riformista che hanno sempre caratterizzato la lunga marcia del sindacato italiano, e ciò ha prodotto tanti distinguo sul ruolo che dovesse avere nella società e sull’utilizzo degli strumenti di contestazione.
Ad acuire le tensioni fra le componenti hanno pesato anche le diverse valutazioni che di volta in volta venivano fatte sulle lotte, in particolare sull’attribuzione della caratteristica di sciopero politico o meno, sui rapporti con i partiti, in alcuni casi anche sui contenuti delle piattaforme rivendicative e non ultimi gli effetti importati a causa di accadimenti esterni.
Un primo momento di divisione sullo sciopero generale fra le organizzazioni fu la proclamazione dello sciopero generale da parte della maggioranza comunista dell’unico sindacato, dopo l’attentato a Togliatti del 14/7/48, proclamato per lo stesso giorno. Dopo due giorni faticosamente la situazione rientrò anche grazie alle sollecitazioni rivolte dallo stesso Togliatti ai lavoratori che manifestavano. Le divisioni però proseguirono con la nascita di Uil e della Cisl, nel 1950, fuoriuscite dall’unica organizzazione sindacale di allora.
Negli anni successivi la nascita dei cobas e di tante piccole sigle autonome, non avendo accettato di autodeterminarsi cosi come previsto dalle norme, aumentarono di molto il conflitto nel Paese e di fatto spesso le dichiarazioni di sciopero si sovrapponevano. Nonostante gli interventi della Commissione di Garanzia non venivano per niente evitati questi continui scioperi corporativi, con l’esito che le valutazioni della Commissione finivano per valere solo per i sindacati confederali.
In questi anni travagliati di grandi stravolgimenti politici, di riproposizione di un bipolarismo più accentuato e di fronte alle adesioni più da tifosi che da protagonisti oggettivi delle vicende politiche, le organizzazioni confederali si sono divise nella valutazione e nella proclamazione dello sciopero generale. Ci sono stati tanti momenti in cui la Cgil ha proclamato tali scioperi autonomamente, perché non erano condivisi da Cisl e Uil. Le divisioni sono avvenute in particolare sulle valutazioni delle scelte delle politiche economiche e sociali da parte dei governi specialmente di centro destra.
Oggi se non si vuole delegittimare lo sciopero generale si deve riproporre l’obiettivo di costruire una nuova unità d’azione fra le tre confederazioni. Si tratta di costruire percorsi di democrazia chiari e nuovi per valutare quando utilizzare questo estremo strumento, perché voglio ricordare che il ruolo del sindacato e di fare accordi a prescindere da chi governa e non di proclamare sciopero. Bisogna evitare, di fonte alla proclamazione dello sciopero, che non solo l’opinione pubblica si ritenga lesa, ma anche che i lavoratori non si sentano partecipi alla decisione.
Si tratta di proseguire un’azione per spiccare un ulteriore salto di qualità in termini di strategia, strumenti di lotta, presenza nell’opinione pubblica di grande respiro, con un’opera di informazione sulle decisioni e di sensibilizzazione sui contenuti e sull’esito dei risultati reali.
[i] P. Calamandrei, Il significato del diritto di sciopero, in Riv. giur. lav, 1952, I, p.221 ss.