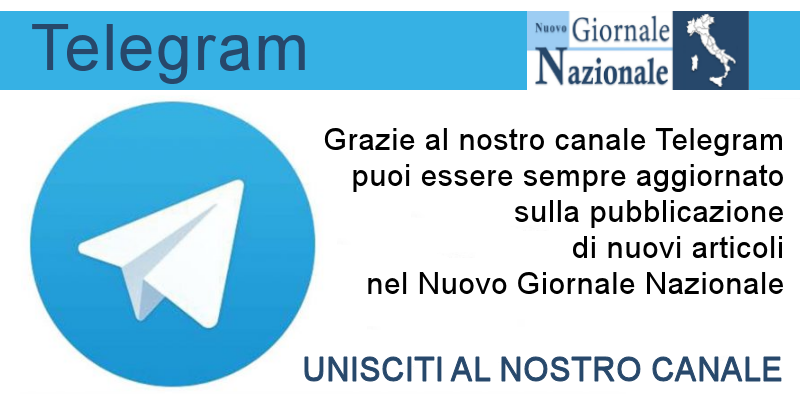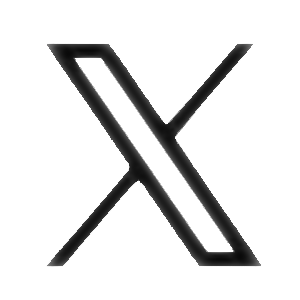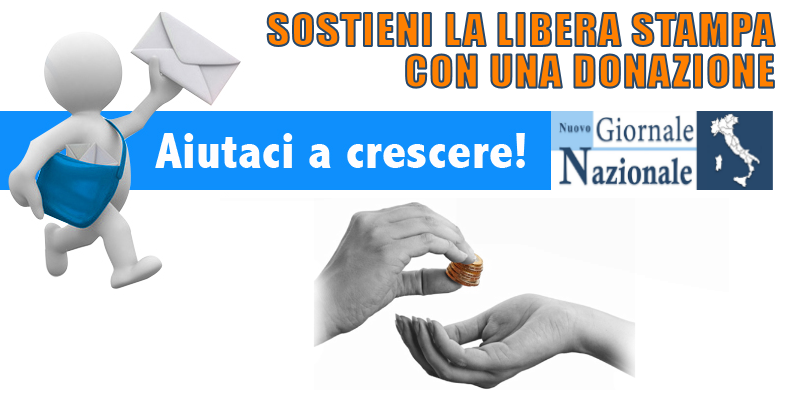di Roberto Caucchioli*
Con le parole si può costruire un mondo, ma, è altrettanto vero che parole inappropriate lo possono distruggere. Qualcuno, in un tempo lontano, scrisse che il Dio della Bibbia creò ex nihilo il Mondo, lo creò dalla profondità del nulla, con la sola forza della parola, espressione autentica del logos divino, dal pensiero di pensiero, dove ha sede la somma ragione.
Wittgenstein, circa un secolo fa scriveva che i limiti del linguaggio rappresentano i limiti del nostro mondo e del nostro pensiero. Le parole non sono meri significanti, sbiadite immagini della realtà fattuale. Le parole sono pietre, mattoni, legno, carne e sangue, sono “forma di vita.” Intendendo con questa affermazione che il codice linguistico di una società è in diretta relazione con i suoi comportamenti. Le parole danno forma e sostanziano le cose e sono il metro di valutazione dei comportamenti sociali.
L’epopea dell’uomo è attraversata e descritta nelle sue ascese come nelle sue cadute dalle parole, scritte o pronunciate. Non avremmo memoria del nostro passato né possiamo immaginarci un futuro senza parole che lo descrivano nel suo realizzarsi. Le parole curano, confortano, tengono viva la memoria, ma, se usate in modo inappropriato, sono il più potente dei veleni.
Un veleno ammorbante, pestilenziale che si insinua nella società, scardinandola nelle sue fondamenta, con la corruzione delle coscienze individuali e collettive. Nel secolo appena passato anni di propaganda antisemita in Germania, e non solo, hanno contribuito a spalancare prima le porte dei lager nazisti e poi quelle delle camere a gas, tutto nell’assordante silenzio dell’indifferenza, o, ancor peggio, con la complicità più o meno conscia del popolo tedesco e quelli di altri stati d’Europa, che hanno taciuto e voltato la testa davanti all’olocausto che si stava compiendo. Un cupo capitolo della storia recente di cui tuttora non abbiamo compreso le profonde implicazioni. Perché dalla narrazione post bellica del “mai più” siamo rapidamente transitati ad un nuovo “gioco linguistico,” per molti versi analogo a quello degli anni 30 del Ventesimo secolo.
L’attualità dei nostri giorni sembra dar ragione al pessimismo di Hobbes nei confronti dell’uomo inteso come animale sociale.Recentemente, in modo sempre più preoccupante, la dialettica politica basata, almeno formalmente, sul confronto fra possibili Weltanschauung, ha ceduto il passo a discorsi imbevuti di violenza, emessi da esseri afoni di ragionamenti. Soggetti politici che, per sopravvivere, sono costretti a inventare sempre nuovi immaginari nemici su cui scaricare i loro fallimenti.
In un mondo dominato in gran parte da politiche autocratiche, anche la Democrazia, vanto dell’Occidente, sembra ormai alle corde. Finiti i tempi dell’impegno “eroico” vissuto nel ricordo della liberazione dalla tirannide oggi all’impegno politico, alla responsabilità della libertà, si antepongono gli interessi privati, secondo il principio insito nella cultura occidentale per la quale la salvezza economica e ultraterrena è un fatto strettamente individuale. In questa società, che definisco post politica, quello che conta è il successo, misurato sul potere che conferisce la ricchezza. Questo solipsismo funzionale non ha bisogno della democrazia, che giudica troppo lenta, troppo incline ai compromessi, troppo sociale, flessa sulle necessità di quelli rimasti indietro, degli abitanti delle periferie del Mondo. Chiede una nuova classe politica che ha come modello, come leader naturale l’homo oeconomicus, quello che meglio di altri ha raggiunto lo scopo che si è dato: la massimizzazione della ricchezza personale, costi quello che costi. Un Leader a cui tutto è concesso, per il quale l’amico di ieri si può sempre tradire in nome dell’interesse e l’avversario politico, il nemico nel linguaggio corrente, può diventare il miglior amico di domani, se serve per mantenere il potere.
Ora questi nuovi leader, formalmente democratici, perché eletti con il consenso della maggioranza, sono tentati di riscrivere le regole della democrazia. Contestano la suddivisione dei poteri, che a loro parere rallentano le decisioni importanti, si oppongono o almeno tentano di riformare il sistema della giustizia, ma soprattutto stanno cambiando le regole del linguaggio politico. Per cui l’avversario politico diventa un nemico da odiare; l’alleato che non si piega repentinamente ai diktat del momento un parassita. Tutti nemici di tutti, sempre sul piede di guerra, si … perché la parola guerra, con i suoi correlati, sono diventate di moda. Locuzioni come competizione, dibattito, trattativa, scambio di opinioni vanno via via scomparendo, e l’etica, la giustizia, la pietas romana … non pervenute. Queste ultime lasciamola pure ai “profeti disarmati” di machiavelliana memoria.
*Società Libera