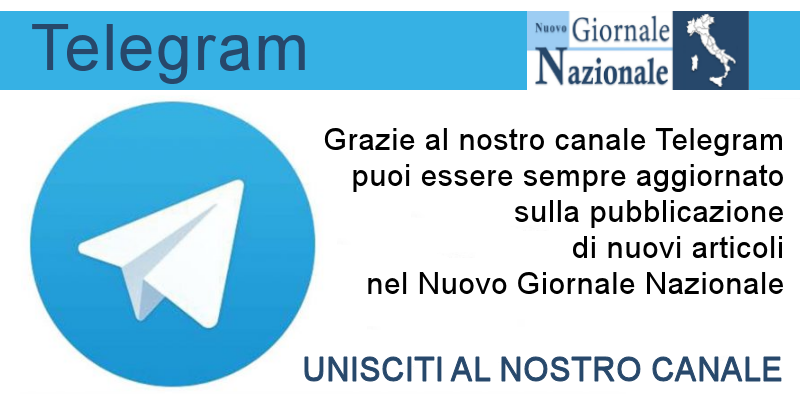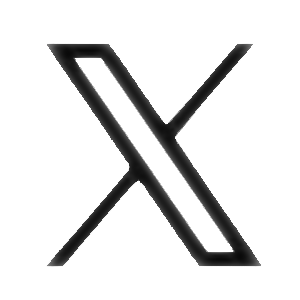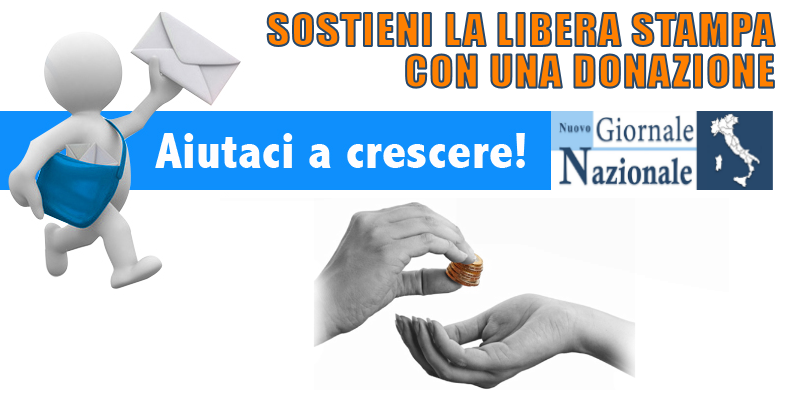La sinistra che si è persa da sola
“La libertà è sempre la libertà di chi pensa diversamente.”
— Rosa Luxemburg
La sinistra. Pronuncio questa parola e sento un sapore di ferro e malinconia, come se avessi in bocca un chiodo arrugginito. Una parola che un tempo scaldava, che odorava di sezioni fumose, di caffè nero e inchiostro, di compagni che credevano davvero che la giustizia fosse un’arte, non un mestiere. Oggi, quella parola è un guscio vuoto, un’eco che non trova più pareti da rimbalzare.
Io nella sinistra ci ho creduto. Non come in una dottrina, ma come in un respiro morale, una postura dell’anima. Ci ho creduto con la fiducia cieca di chi pensa che la cultura possa redimere il mondo. Ora, vederla svanire, sfilacciarsi in gesti retorici e in indignazioni effimere, fa male come un lutto non compiuto. È il dolore di chi riconosce una voce amata e la sente spegnersi in una lingua che non capisce più.
Dopo il muro: la fuga nel nulla
La caduta del Muro di Berlino avrebbe dovuto liberarci dal dogma, non dal pensiero. E invece la sinistra italiana, rimasta orfana del suo mostro, si è rifugiata nel nulla. Ha sostituito la lotta con la rappresentazione, la realtà con la percezione. Ha smesso di parlare di lavoro, di sudore, di salari, e ha cominciato a parlare di sé. Ha trovato nel linguaggio dei diritti civili un rifugio comodo, e ha dimenticato il linguaggio del pane.
Non c’è nulla di sbagliato nei diritti civili, ma è tragico quando diventano un surrogato di giustizia sociale. Si è smarrito il popolo, e nessuno sembra cercarlo. Mentre si discute di pronomi e definizioni, intere generazioni imparano a chiamare “flessibilità” la precarietà, “libertà” l’assenza di tutele.
La memoria amputata
Il dramma non fu l’aver rinnegato il passato, ma l’averlo amputato. Nessuna elaborazione, solo rimozione. Come se il comunismo fosse stato una malattia da dimenticare, non una ferita da curare. Così, nell’ombra, è cresciuto il drago: l’antiamericanismo di riflesso, la tenerezza per ogni regime che si proclami antioccidentale, la nostalgia per un mondo che non è mai esistito.
Ricordo le lezioni di Domenico Susi, che mi fu maestro nel campo civile: uomo di misura e di passione, capace di insegnare la politica come servizio, non come carriera. Accanto a lui, Attilio Cecchini, vigoroso giornalista de Il Paese Sera, redattore in America Latina, amico di Che Guevara, di Gabriel García Márquez e di Mario Vargas Llosa. Uomini che avevano conosciuto la Storia da vicino, che l’avevano toccata con le mani, sporcandosi di realtà e di ideali.
E prima ancora, come fari lontani, Ernesto De Martino, Giuseppe Saragat, Bettino Craxi — tre visioni diverse, ma unite dalla convinzione che la sinistra dovesse essere concreta, laica, pensante. De Martino, con la sua antropologia del dolore e del riscatto, ci ricordava che la cultura è un gesto di salvezza collettiva. Saragat, con il suo socialismo democratico, salvava l’idea di libertà dentro la giustizia. Craxi, con tutti i suoi errori, difendeva la modernità e la responsabilità del potere contro la tentazione dell’alibi morale.
Loro avevano un’idea, non un riflesso. Avevano una direzione.
Il moralismo come ideologia
Oggi la sinistra non pensa più: giudica. Non cerca: corregge. È diventata un tribunale che assolve solo sé stessa. Un tempo costruiva fabbriche di idee, oggi gestisce uffici di censura. Si è rifugiata nel moralismo come in una nuova religione: non c’è più il proletariato da redimere, ma l’umanità da educare.
E così il dialogo è morto. Chi non aderisce viene escluso, chi dubita viene sospettato. È una sinistra che non seduce più: intimorisce. Che non include: seleziona. Il suo linguaggio è quello delle campagne social, delle indignazioni a tempo determinato, dei manifesti senza sudore.
Intanto la realtà scorre altrove: nelle fabbriche chiuse, nei quartieri stanchi, nelle periferie che non hanno biblioteche ma solo scommesse e supermercati notturni.
La perdita della realtà
Un tempo la sinistra parlava la lingua della vita. Oggi parla il gergo dei convegni. Vive nei talk show, nei podcast, nei festival dell’anima progressista. Ma il mondo reale non ha microfoni, ha bollette. Non ha opinioni, ha ferite.
Si è persa la concretezza, quella capacità di sentire la terra sotto i piedi. La sinistra, che un tempo voleva cambiare la Storia, oggi teme di cambiare sé stessa. È diventata conservatrice del proprio specchio, innamorata del proprio riflesso.
Siamo rimasti orfani
Io mi sento orfano. Non di un partito, ma di un respiro collettivo.
Avevamo creduto che la sinistra fosse la casa del dubbio, del pensiero libero, del coraggio di sbagliare. Invece è diventata la casa della paura, del conformismo morale, della purezza come arma di esclusione.
Chi, come me, ha camminato con maestri veri — Susi, Cecchini, De Martino — non riesce a riconoscere in questa sinistra digitale e clericale qualcosa di vivo. Non c’è più il desiderio di capire, ma solo quello di aver ragione. Non c’è più la passione per il mondo, ma la paura di sporcarsi con esso.
Cosa resta da salvare
Eppure, qualcosa resta. Una brace sotto la cenere. L’idea che la giustizia non sia un orpello ma una necessità vitale. Che la cultura non serva a distinguersi, ma a unirsi. Che l’uguaglianza non sia una parola vecchia, ma il fondamento della libertà.
Resta la speranza che da questo lutto possa nascere una rinascita. Ma prima bisogna piangere davvero. Ammettere di aver fallito. Di essersi borghesizzati, anestetizzati, resi sterili dal culto della forma. Solo da quel dolore, solo da quella onestà, può rinascere una sinistra degna di essere amata.
Epilogo
Forse, come nella favola del piccolo Billy, la sinistra voleva solo essere notata. Ma a forza di voler piacere si è gonfiata fino a sradicare la casa. Ora resta il vuoto, e qualche superstite che raccoglie le macerie per non dimenticare.
Io continuo a cercarla. Nei gesti quotidiani di chi aiuta senza proclami, nelle parole di chi ancora studia, nei silenzi di chi non smette di credere.
La cerco nei volti dei maestri scomparsi — Susi, Cecchini, De Martino, Saragat, Craxi — e in quella lezione che non invecchia: la giustizia è un atto di coraggio, non di convenienza.
Forse lì, tra chi non si arrende, arde ancora una piccola fiamma. E finché qualcuno la custodirà, la sinistra, quella vera, non sarà mai del tutto perduta.