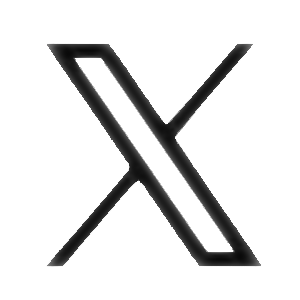di Aldo A. Mola
Ma davvero incombe “lo nero periglio”?
In un recente articolo Ernesto Galli della Loggia ha evocato la diversità radicale tra i “Paesi occidentali” e quelli islamici, estesi «dalle pendici dell'Himalaya alle coste dell’Atlantico». Nei primi – sintetizzando il suo scritto – vige la libertà personale, che «significa il rispetto della libertà degli altri, di chiunque altro, significa quella cosa che si chiama tolleranza». I secondi non conoscono e quindi non praticano né l'una né l'altra. Poiché «la migrazione dai Paesi islamici, anche quella di seconda o terza generazione, tende a mantenere, spesso addirittura a rafforzare, un'insuperabile separazione culturale, legata alle proprie radici», se in Italia non si trova per tempo una qualche soluzione «andiamo incontro a un futuro tempestoso». Un «Paese serio – egli conclude – discuterebbe con mente aperta tutte le opzioni possibili e tenendo conto solo di un vincolo: che per la Repubblica libertà e tolleranza sono valori assolutamente non negoziabili».
Pienamente d'accordo sulla necessità di un dibattito nel Paese e nelle sedi deputate a legiferare (il Parlamento, senza dimenticare il sempre più necessario vaglio del Quirinale e della Corte costituzionale), a far osservare le leggi e ad amministrare la giustizia (la Magistratura: che non è un “potere”, ma un “Ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”), proprio perché pone al centro il cosiddetto “jure condendo” il mònito lanciato da Galli della Loggia offre motivo di alcune osservazioni. Al tempo stesso occorre evitare proposte e/o varare in clima di falsa emergenza ricette per problemi inesistenti o diversi da come vengono “narrati”.
I pochi e la medicina del tempo
La libertà dell'uomo è anelito antico, ma, superfluo dirlo, di poche persone. Negli ordinamenti costituzionali la sua enunciazione è recentissima e ristretta a pochi tra gli Stati che siedono nell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Benché calpestino al proprio interno le più elementari libertà, molti di essi hanno posizioni eminenti nei consessi giuridici internazionali. Anziché stigmatizzarli, lasciar fare e barattare ideali con merci, bisogna chiamarli a rispondere.
Libertà e tolleranza non sono affatto tutt'uno: sono concezioni e realtà separate. Nell'impossibilità di tracciarne una panoramica universale, va ricordato che, per rimanere all'“Europa”, nell'antichità greco-romana la libertà intesa quale possesso ed esercizio di diritti “politici” era privilegio di chi aveva piena “cittadinanza”. Perteneva a esigue minoranze. La cittadinanza non comportava la condivisione di culti. Diritti “politici” e pratiche religiose erano separati. I cittadini di pieno diritto si riconoscevano in Roma, ma Roma non esigeva che la pleiade dei popoli via via assoggettati e meno ancora gli innumerevoli schiavi di cui si servivano adottassero la sua “religiosità”.
Roma non ebbe preclusioni verso alcuna “credenza” se quanti la praticavano non entravano in conflitto con le leggi. Costumi, credenze e religioni erano mondi separati. Il potere, infine, non entrava nella pratica di “riti” e dei “misteri”, avvolti nella discrezione.
Il declino dell'impero e l'ascesa del monoteismo intollerante
La compatibilità tra “politica” e “religione” si pose o, se si preferisce, esplose, quando una religione risultò in conflitto con lo Stato e ne rifiutò l'ingerenza nella propria “pratica”. Molto semplificando per necessità di sintesi, fu il caso dei “cristiani” che vennero vessati perché rifiutavano l'omaggio di rito allo Stato, raffigurato nelle fattezze dell'imperatore: un “caso” che si pose solo sulla fine del primo secolo dopo Cristo. La loro persecuzione durò per secoli ed ebbe ritmi alterni, in parte connessi all'annientamento dello “Stato” ebraico (conquista di Gerusalemme nel 70 d.C. da parte di Tito Flavio) e alla diaspora degli ebrei dopo la distruzione del Tempio ordinata da Adriano.
Mentre nei confini dell'Impero dilagavano senza divieti né ostacoli i culti più disparati, talora non privi di eccessi e persino di efferatezze, ma sempre nell'ambito di culti connessi alla “natura” e alle sue molteplici raffigurazioni, il cristianesimo rimase quanto meno sospetto se non esplicitamente nemico e quindi proibito.
Per quanto paradossale, a concedere la cittadinanza romana a tutti gli uomini dell'Impero fu Marco Antonino Caracalla , «uomo di corrotti costumi e più crudele del già crudele suo padre; avido di cibo, come pure ingordo di vino, odiato dai familiari e detestato da tutti i soldati, ad eccezione dei pretoriani», come narra Elio Sparziano nel suo profilo raccolto nella Storia Augusta. Fratricida e incestuoso, venne infine assassinato. Però fu proprio lui a emanare nel 212 d.C., la “Constitutio Antoniniana”, nota anche come “editto di Caracalla”, dal suo soprannome. La massima indifferenza dello Stato verso i culti si coniugò con la loro moltiplicazione, a cominciare da quelli “orientali” (egizi, siri...), a eccezione, come detto, dei cristiani.
Il primo editto di tolleranza verso quanti praticavano il Vangelo venne emanato il 30 aprile 311 d.C. dall'imperatore augusto Galerio in Serdica (attuale Sofia) dopo un decennio di feroce persecuzione dei cristiani, ordinata da Diocleziano e attuata dai tetrarchi, lui compreso. Galerio fu molto chiaro. Aveva perseguitato i cristiani (anche a morte) perché si erano posti in conflitto con le antiche leggi e le istituzioni romane. “Melius re perpensa”, forte della propria benevolenza e incline alla clemenza aveva deciso di perdonarli e di autorizzarli a ricostruire «gli edifici nei quali erano soliti riunirsi, a condizione che essi non si abbandonino ad azioni contrarie all'ordine costituito». Da banditi e perseguitati i cristiani risultarono dunque non liberi ma tollerati nell'ambito delle leggi universali dell'Impero. L'editto emanato a Milano da Costantino due anni dopo non andò molto oltre, anche perché, già devoto ad Apollo e conscio che il suo rivale Massenzio era largo di concessioni ai cristiani, egli era, sì, d'accordo sulla necessità di tollerarli per averli alleati nello scontro finale consumato con la battaglia di Ponte Milvio (28 ottobre 313 d.C.) e l'eliminazione dello stesso Massenzio, ma senza prevalenza su altri culti.
Quegli editti furono l'ultimo vagito della “tolleranza” e non si tradussero affatto nel trionfo della “libertà di culto”. Anzi, per motivi politico-militari complessi, divenuto unico “Augusto”, Costantino ribadì il primato dell'imperatore nelle questioni religiose. Con il patrocinio esercitato sul concilio di Nicea (325 d.C.) prese posizione netta a favore dei cristiani “romani” contro i cristiani ariani, classificati eretici e, come tali, banditi e perseguitati nei modi più feroci.
Anche la rassegna più breve delle “eresie” che fiorirono nei primi secoli del cristianesimo richiederebbe molto spazio e farebbe perdere di vista ciò che più conta evidenziare: gli editti di tolleranza fecero da volano alla divisione definitiva del cristianesimo in professioni diverse, reciprocamente ostili e, quando lasciate libere di agire, contrapposte in lotte feroci e implacabili, l'opposto della tolleranza e, ancor più, della libertà di culto.
La breve riscossa neo-pagana di Giuliano (331-363 d. C.), nipote di Costantino, scampato alla strage di parenti da questi ordinata quando si approssimò alla morte, si risolse nell’incompatibilità patente tra “cristiani” e “pagani”, poi suggellata con la rimozione dell'Altare della Vittoria dall'Aula del Senato e con la demonizzazione del culto di Mitra, largamente diffuso nelle legioni. Già vittorioso sugli Alamanni nella battaglia di Strasburgo e ferito a morte in quella di Ctesifonte mentre combatteva i Persiani, secolare nemici di Roma, con le misure adottate a carico dei cristiani il neoplatonico Giuliano, poi spregiativamente detto “Apostata”, ovvero traditore, aprì involontariamente la strada all'editto emanato in Tessalonica (27 febbraio 380 d. C.) a nome degli imperatori Graziano, Teodosio e Valentiniano II (di soli nove anni). Questo chiuse la breve stagione della “tolleranza” e decretò che il cristianesimo cattolico (Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio uno e trino) professato da papa Damaso, successore di Pietro Apostolo, era la religione ufficiale dell'impero. Gli altri cristiani furono declassati a “dementes”, condannati al castigo divino. Divennero bersaglio delle leggi imperiali, forti dell'investitura celeste. Teodosio fu il primo assertore nel canone “Dio è con noi”.
Qualunque scelta (=eresia) diversa dalla cattolica divenne “crimen publicum”, uno scandalo da annientare con l'eliminazione fisica degli eretici. Nella tenaglia tra autorità imperiale e condanna teologale finirono stritolati i pagani e i cristiani dissidenti. In molti casi anche illustri ecclesiastici, come Giovanni Crisostomo, guidarono folle di fanatici a farsi “giustizia” con l'assalto a templi e con la strage degli “infedeli”. “Tantum potuit religio suadere malorum” aveva scritto nel “De Rerum natura” l'epicureo Tito Lucrezio per deplorare i delitti perpetrati per suggestione superstiziosa. E la Buona Novella?
Dal crollo...
Qualche decennio addietro anche in Italia si diffuse il mito dei Longobardi e di altri popoli che vi irruppero dopo il tramonto dell'impero romano “in Occidente”: un termine vago, italo-centrico e infido, poiché da oltre un secolo nelle Gallie e in Iberia esistevano “potentati” separati da Roma. L'“Italia” non c'era; e non se ne parlò più per quindici secoli. I suoi problemi furono altri. Essi non vanno lasciati nelle nebbie di “secoli bui” e di altre formule fonte di confusione.
L'impero romano crollò per motivi che da secoli sono croce e delizia di storiografi e di chiromanti. Al di là di suggestioni (il saturnismo, indotto dal troppo piombo contenuto nel vasellame d'uso quotidiano), l'impero si esaurì con il fallimento delle guerre secolari contro la Persia, con la rinuncia a conquiste nell'Europa settentrionale, poco redditizia di risorse e di schiavi, per le guerre interne fratricide e per l'indebolimento della struttura dello “Stato” sin dalle guerre civili e dal fallimento dei due triumvirati, che cercarono di traghettare il regime dalla senatocrazia al principato.
Premesso che ogni Grande Potenza attuale sarebbe felice se le venissero predetti quattro-cinque secoli di “decadenza”, quanti appunto (secondo i manuali di storia) furono quelli dell'Impero nell'“Occidente” (nel “putrido Oriente” bizantino l'impero durò un altro millennio, a conferma che una lunga malattia è meglio della morte), una constatazione s'impone con riferimento all'Italia.
Tra guerre goto-bizantine, che desertificarono il Mezzogiorno, irruzione dei Franchi e restaurazione dell'impero in Occidente con gli Ottoni di Sassonia (quanti a sud del crinale alpino vi si installarono e figliarono? quanto incisero sulla vita quotidiana del “popolo disperso” e dei borghi ove un tempo v'erano città fiorenti?), unica certezza è che la polverizzazione dell'Impero romano spianò la strada all’esplosione dell’Islam.
...all'invasione islamica
Dopo l'ègira di Maometto (“trasferimento” per gli uni, “fuga” per altri) da La Mecca a Medina (622), il suo rientro trionfale a La Mecca (630) e la fondazione della comunità musulmana (“umma”) subito dopo la morte del Profeta (632), l'islamismo arabo dilagò “manu militari”. La guerra santa, alimentata dalla promessa della non spiacevole salvezza iperurania ai caduti per la sua causa, in pochi anni portò alla conquista di Mesopotamia, Siria (636), Gerusalemme (638), Persia (644), Egitto (642-646), Cirenaica (644) e Cappadocia. Anche gli islamici si sentirono sicuri di avere Dio dalla loro. Dal 648, allestita per la prima volta una flotta, conquistarono Cipro, Creta, Rodi e iniziarono ad aggredire la Sicilia. Sconfissero un'armata navale bizantina, soggiogarono il Maghreb, si spinsero ad assediare Costantinopoli e iniziarono scorrerie in Calabria, Sardegna, Corsica, Nizza.
Nel 711 una spedizione capeggiata da Tariq sbarcò in Spagna, rapidamente sottomessa: Siviglia, Cordova, Toledo... Poi fu la volta del Portogallo. Nel 732 i musulmani raggiunsero Bordeaux, nell'antica Aquitania. Vennero fermati dal franco Carlo Martello a Poitiers (732, o 733 secondo altra cronologia) ma ripresero ad avanzare sino ad Avignone, mentre dalla Costa Azzurra i “Saraceni” salirono in Piemonte, sino a saccheggiare Alba, Susa... Superfluo sottolineare che di volta in volta uccisero quasi tutti gli uomini anziani o palesemente invalidi e deportarono bambini e soprattutto donne, previo accertamento dei loro attributi.
Le scorrerie colpirono l'abbazia di Montecassino e Ostia e lambirono Roma. Papa Leone fece alzare le mura a strenua difesa del cuore della Cristianità. Quando l'uragano islamico scese d'intensità come sempre accade nel tempo i “cristiani” risposero con le Crociate e la fondazione di effimeri regni nella Terrasanta, con un “passaggio” a Bisanzio ai danni dell'impero d'Oriente (1204). Molti anteponevano i trenta denari al Vangelo.
Placata, o quasi, l'offensiva degli islamici iniziò la guerra tra “occidentali”. Quale tolleranza? Quale libertà? Gli “albigesi”, fulcro di una leggiadra civiltà, vennero sterminati senza pietà alcuna. Un ecclesiastico insigne, Arnaldo Amalrico di Citeaux, a chi gli domandava come risparmiare i “fedeli” nell'assalto finale sentenziò: «Uccideteli tutti. Dio sceglierà i suoi». Sempre Dio.
Nel 1453 i turchi espugnarono Costantinopoli e ne sterminarono la popolazione. Vennero risparmiati gli artigiani utili per rimediare ai danni dell'assedio. La città divenne turca e tale rimane, dopo i congressi di pace di Vienna, Parigi, Versailles, Postdam, perché così volle l'Europa “cristiana occidentale” in odio contro la Russia cristiana ortodossa e, più prosaicamente, per il controllo del commercio tra Mediterraneo e Mar Nero attraverso gli Stretti.
La catastrofe del Cinque-Seicento e la tratta degli schiavi
Settant'anni dopo l'espugnazione di “Cospoli”, il celebrato “Occidente”, proprio mentre scopriva il mondo grazie alle esplorazioni, sprofondò nella lunghissima guerra tra cattolici, protestanti, evangelici, anabattisti... Tutti “cristiani”, tutti dediti a crimini agghiacciati. Con la pace di Augusta venne sancito il principio “cuius regio, eius et religio”. I sudditi dovevano professare la “religione” del loro sovrano. Convertirsi o andarsene. Le guerre di religione sono durate secoli. Come lo schiavismo. Un tempo erano i saraceni a predare gli europei. Almeno un milione vennero ridotti in schiavitù. Poi gli europei prelevarono sulle coste atlantiche dell’Africa i “negri” che i mercanti islamici catturavano e vendevano ai migliori offerenti. L'8 febbraio 1815 i plenipotenziari riuniti a congresso in Vienna decisero di porre termine al «flagello della tratta dei negri che aveva desolato l'Africa, degradato l'Europa e afflitto l’umanità». Era ripugnante. Quel “voto” però non venne sottoscritto da Spagna e Portogallo. La Francia, presente al Congresso con il principe Talleyrand, antico vescovo di Autun e ministro degli Esteri per tutte le stagioni, abbozzò ma non applicò. La Francia aveva bisogno di schiavi, come ne avevano gli Stati Uniti d'America che non presero parte al congresso. La Gran Bretagna aderì, perché la Dichiarazione impegnava i governi a provvedere in un imprecisato futuro.
Tolleranza? Libertà? La celebre “costituzione di Cadice” che dopo il 1815 venne presa a modello dai liberali italiani prescriveva che la religione di Stato era la cattolica. Gli altri culti non erano ammessi. Lo Statuto del regno di Sardegna emanato da Carlo Alberto il 4 marzo 1848 proclamò invece che «Tutti (i regnicoli) godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari salvo le eccezioni determinate dalle leggi». Toccava dunque al Parlamento provvedere. Venne anticipato dai decreti del Luogotenente Eugenio di Savoia che conferì tutti i diritti anche agli ebrei. In un Paese poco avvezzo alla libertà, dopo l'unificazione del 1861 ci vollero generazioni per tradurre i principi ideali in realtà effettuale: un processo lento, comune a tanti altri Stati europei, mentre negli Stati Uniti d'America l'uguaglianza rimane ancora uno slogan. In Italia nel 1938 fu ancora un Parlamento ad approvare leggi razziste, con grave imbarazzo ma nessun dissenso pubblico della Santa Sede. Per motivi più volte spiegati da un quarto di secolo in opere edite anche da Mondadori e Bompiani, ma forse ignote a qualche giornalista come Aldo Cazzullo, esse vennero firmate da Vittorio Emanuele III. Eliminato il regime fascista, la monarchia le abolì. Altri impiegarono decenni a cancellare l'imputazione di “deicidio” ai “perfidi giudei”.
L'articolo 3 della Costituzione vigente enuncia: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.» Il “passato”, con tutti i suoi errori, venne consegnato alla storia. L'articolo 8 precisa: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni diverse dalla cattolica [i costituenti non aggiunsero “cristiana”, perché sottintesa: ma sarebbe stato meglio scriverlo] hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti [termine non appropriato], in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.»
Forse vi era un difetto di cognizione delle confessioni diverse dalla cattolica. Non tutte hanno “statuti” e, ciò che più conta, non tutti i cittadini si debbono riconoscere in confessioni ma hanno diritto alla propria libertà di fantasticare o di non occuparsi affatto di “cose dell'altro mondo”. Per essere uomini probi basta e avanza impegnarsi a migliorare o almeno a conservare “l'aiuola che ci fa tanto feroci”.
In prossimità del 17 febbraio, festeggiato dai valdesi in ricordo delle regie patenti che nel 1848 li “parificarono” ai cattolici e ricordato da quanti non dimenticano il rogo che quello stesso giorno del 1601 arse vivo l' “eretico” Giordano Bruno da Nola in Campo de' Fiori a Roma, giova distinguere nettamente la “libertà”, diritto non negoziabile (come scritto da Galli della Loggia), dalla “tolleranza”, dispensata dal sovrano al suddito. Sono “cose” distinte e distanti: da tenere presenti “de jure condendo”. È tempo di ripartire dal filosofo del dialogo, Guido Calogero. Il fondamento della convivenza all'interno di ciascuno Stato e nel mondo venturo sono la conoscenza reciproca, il confronto, il dialogo. E' un cammino lungo; ma non ha alternative. Chi visita un Museo, ne esce più consapevole dei “cento fiori”, più maturo, più curioso e meno presuntuoso di possedere la verità innata. Il Mondo è il Museo.
DIDASCALIA: Guido Calogero, filosofo del dialogo.
Guido Calogero (Roma, 1904-1986), di famiglia messinese, storico della filosofia antica, libero docente dal 1927 e ordinario all'Università di Pisa dal 1934, invitato da Giovanni Gentile alla Scuola Normale di Pisa e clandestinamente antifascista militante, nel 1940 scrisse con Aldo Capitini il “Manifesto del liberalsocialismo”. Deferito al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, fu destituito dalla cattedra e assegnato a confino di polizia a Scanno (in Abruzzi), ove rivide l'ex allievo Carlo Azeglio Ciampi. Militante nel Partito d'azione, nel 1948 si schierò con il Fronte popolare a favore della laicità dello Stato. Con Arturo Carlo Jemolo e “altri spiriti magni non necessariamente iniziati” (AAM, Storia della Massoneria, 1992, p. 822), rianimò la rivista “La Cultura”, promossa dal Grande Oriente d'Italia. Tra i fondatori del partito radicale (1955), candidato alla Camera dei deputati, ne uscì e confluì in quello socialista. Tra le sue Opere di logico antimetafisico spiccano “Difesa del Liberalsocialismo” (1945) e “Filosofia del dialogo” (1962).