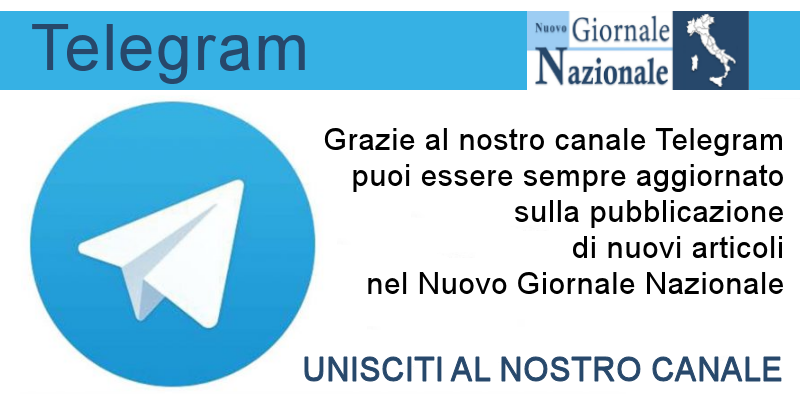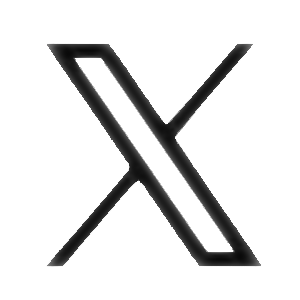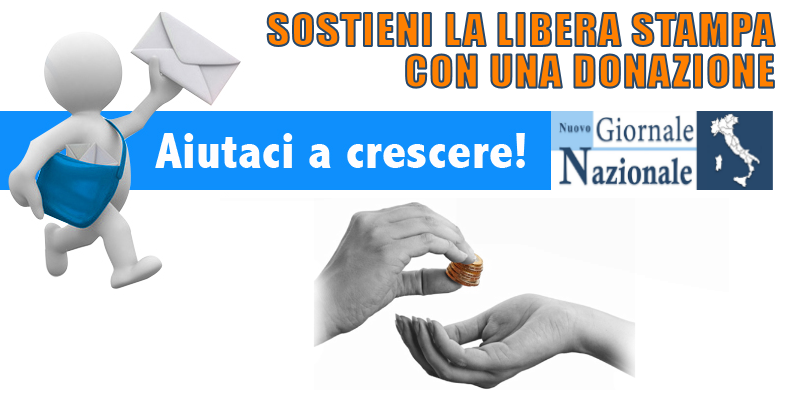di Maurizio Ballistreri
E’ dalla fine del sistema che per convenzione politologica si definisce “Prima Repubblica”, di derivazione ciellenistica, con la conseguente subordinazione, invero su scala globale, della politica al mercato finanziario, che si è prodotto l’oscuramento su una delle grandi questioni irrisolte dopo l’Unità d’Italia: quella meridionale.
Un’affermazione che trova riscontro anche nel varo della manovra economica dell’attuale governo e nell’assenza da parte dell’opposizione, di controproposte che richiamino i temi del Mezzogiorno, cancellati da tempo dalle piattaforme di politica economica e sociale delle confederazioni sindacali cosiddette “storiche”, che invece erano stati assunti come prioritari e mobilitanti nella loro “politica per le riforme” negli anni Settanta del ‘900.
La questione meridionale si presenta ormai suddivisa in tanti capitoli, dalla legalità all’ambiente e al lavoro, senza più una prospettazione unitaria.
Purtuttavia, nel Sud d’Italia emergono segnali di una diversa capacità di fronteggiare, sul piano politico, la rimozione del tema da parte dell’agenda pubblica nazionale, rivendicando attraverso i suoi amministratori dotati di cultura di governo e di civismo, occupazione e sviluppo.
Emerge, così, una volontà di autodeterminazione per opporsi ad una condizione di subalternità, in cui il rango del Meridione è quello di soggetto passivo e nel quale il suo sistema economico deve essere conseguenza delle imperscrutabili scelte del “Principe”, sulla testa delle comunità territoriali, pesantemente viziato da quel “panpoliticismo” che vagheggia forme premoderne di democrazia centralizzata, fondata sul leader.
Il Mezzogiorno non è più il mondo arcaico e rassegnato dei contadini di Gagliano descritti da Carlo Levi. Quella rappresentazione venne superata grazie all’unica fase di convergenza tra Sud e Nord del nostro Paese, tra anni Cinquanta e Sessanta del ‘900, in virtù dell’intervento straordinario basato sugli investimenti fissi in sviluppo industriale e manifatturiero, specie durante il primo centro-sinistra ed il suo slancio riformatore.
A partire dagli anni Settanta, con la progressiva acquisizione di modelli economici neo-liberisti e anti-statalisti, i trasferimenti dell’intervento straordinario hanno cambiato natura trasformandosi in assistenzialismo clientelare e spesa improduttiva.
Da questo cambio di paradigma della visione della questione meridionale, nasce l’attuale condizione del Mezzogiorno di mercato di sbocco per le industrie settentrionali e internazionali, con l’assegnazione solo di forme di economia agro-turistica, cioè a leve che non possono garantire adeguati processi di accumulazione che recuperino il dualismo Nord-Sud, con l’esposizione del Meridione alle incerte congiunture del mercato, penalizzato dalle scelte di un’Unione Europea che continua con le fallimentari politiche monetariste e che avrà gravi conseguenze dall’introduzione dei dazi di Trump.
La conseguenza è l’abbandono dell’obiettivo ineludibile della convergenza nazionale, sacrificato sull’altare dell’attribuzione al Sud del ruolo di territorio di consumo, accompagnato dagli storytelling sul ritorno all’agricoltura, sulle start-up, sulle eccellenze meridionali, mentre migliaia di giovani dotati di know-how hanno preso la strada dell’emigrazione all’estero e il residuo tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno affronta quotidianamente la “guerra” con il non-governo, la burocrazia, il credito, la criminalità, la carenza di infrastrutture materiali e immateriali.
Il tema appare, dunque, la ripresa della riflessione (e dell’azione!) sul modello di sviluppo del Mezzogiorno, depurata dalla vana retorica finto-meridionalista.
Alle classi dirigenti meridionali più avvertite, dunque, il compito di questa azione.